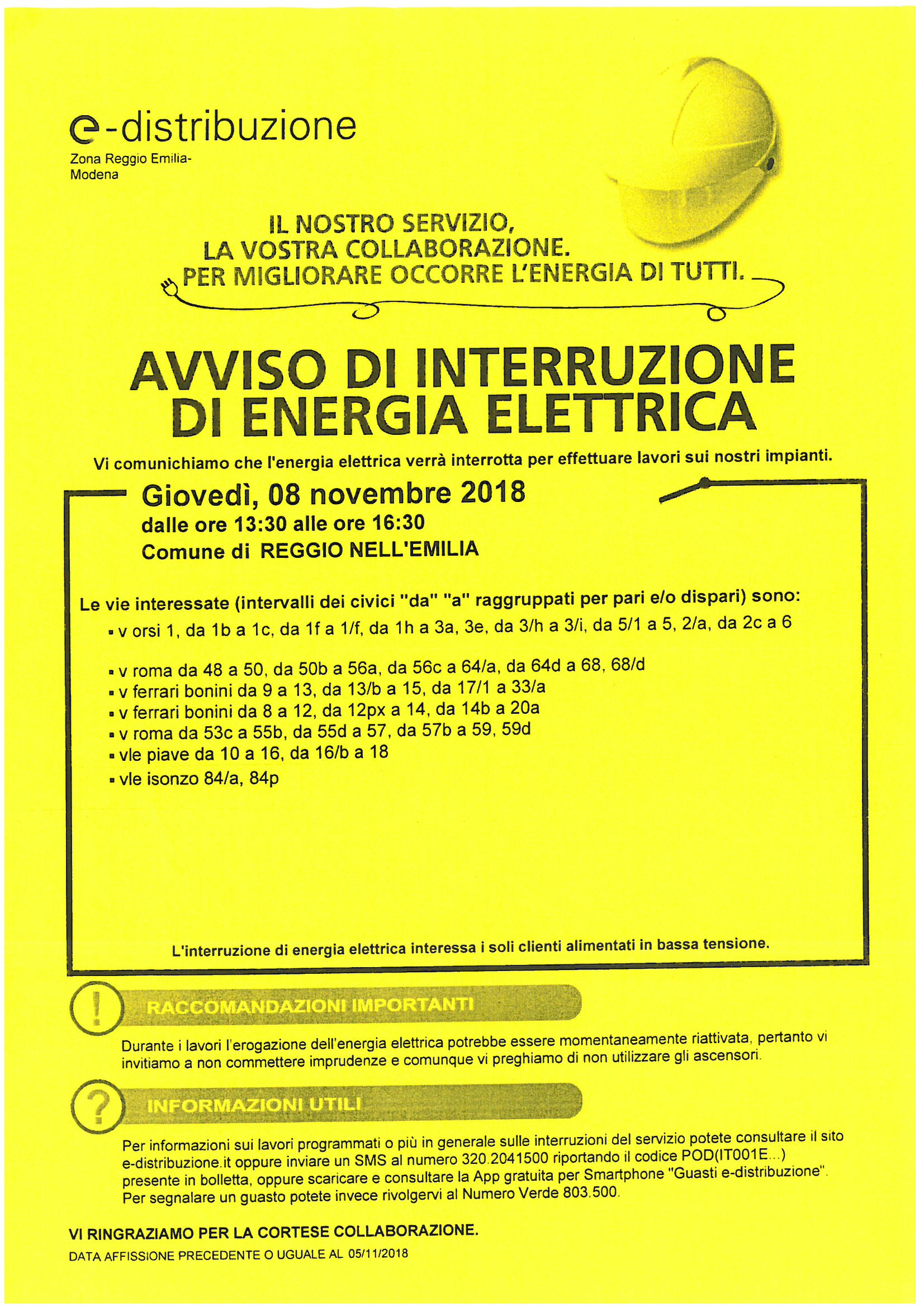La Corte di Cassazione, pur dichiarandola non rilevante nel caso concreto, ha affermato che non pare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 3/2019, nella parte in cui inserisce i reati contro la P.A. tra quelli “ostativi” ai sensi dell’art. 4-bis l. n. 354/1975, senza prevedere un regime intertemporale.
Di seguito le motivazioni integrali della sentenza.
* * *
SENTENZA
sul ricorso proposto da
F.M. nato a Roma il 23/01/1951
avverso la sentenza del 13/06/2018 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata limitatamente alla condanna al pagamento della riparazione pecuniariaexart. 322-quatercod. pen.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha applicato nei confronti di M.F., su sua richiesta, la pena di anni due, mesi nove e giorni dieci di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 319 e 321 cod. pen. sub capo 1) e di cui agli artt. 319, 319-ter e 321 cod. pen. sub capo 2). Con la medesima sentenza, il G.i.p. ha disposto la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ex art. 371-bis cod. pen. e la confisca della somma di 330.000,00 euro ai sensi dell’art. 322-ter cod. pen. ed ha inoltre ordinato all’imputato di pagare alla “ASL Roma 1” la somma di 330.000,00 euro, a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen.
2. Con atto a firma dei due difensori di fiducia, M.F. ha proposto ricorso avverso il provvedimento e ne ha chiesto l’annullamento con limitato riferimento alla disposta condanna al pagamento della riparazione pecuniaria per violazione di legge penale e processuale.
La difesa ha evidenziato al riguardo come il giudice abbia applicato una “pena illegale”, là dove l’art. 322-quater cod. pen. prevede la riparazione pecuniaria esclusivamente in caso di “sentenza” propriamente detta – resa cioè all’esito del giudizio ordinario o abbreviato – e non anche di applicazione della pena.
2.1. In data 27 febbraio 2019, la difesa del F. ha presentato motivi nuovi ex art. 611 cod. proc. pen. con i quali, sotto diversi profili, ha sollecitato questa Corte, «riconosciuta la propria competenza a conoscere della fase esecutiva del presente procedimento», a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lett. b), legge 9 gennaio 2019, n. 3, nella parte in cui ha inserito i reati contro la pubblica amministrazione tra quelli “ostativi” alla concessione di alcuni benefici penitenziari, ai sensi dell’art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, per rilevato contrasto con gli artt. 3, 24, 25, comma secondo, 27, comma terzo, e 117 Cost., 7 CEDU, nella parte in cui non prevede un regime intertemporale.
A sostegno della deduzione, la difesa rileva, sotto un primo aspetto, come – avendo riguardo al combinato disposto degli artt. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. e 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione ai delitti di cui agli artt. 319, 319-ter e 321 cod. pen. (contestati al F.) – in quanto inseriti nel novero dei reati di cui allo stesso art. 4-bis in virtù della novella con legge 9 gennaio 2019, n. 3 -, non sia più possibile sospendere l’ordine di esecuzione ai fini della richiesta di misure alternative alla detenzione in stato di libertà. In assenza di una disposizione transitoria regolativa dei limiti temporali di applicazione della nuova disciplina, con il passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento, l’emissione dell’ordine di carcerazione sarà pertanto “obbligata”, con una modifica peggiorativa del trattamento penitenziario. Modifica peggiorativa “a sorpresa” atteso che, al momento in cui avanzava la richiesta ex artt. 444 e 445 cod. proc. pen., F. poteva ragionevolmente confidare che la sanzione sarebbe rimasta nei limiti di operatività delle misure alternative e dunque “senza assaggio di pena”. Evidenzia, pertanto, come tale modifica in itinere delle “regole del gioco”, in quanto del tutto imponderabile all’atto dell’opzione in rito, si ponga in evidente contrasto con l’art. 7 CEDU, come interpretato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo in situazioni analoghe – rilevante ai fini dell’art. 117 Cost. -, là dove viola il principio dell’affidamento quanto alla prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie (v. per tutte Grande Camera 21 dicembre 2013, Del Rio Prada c. Spagna).
Sotto diverso aspetto, il ricorrente pone in luce come la novella normativa, nel modificare le modalità di esecuzione della pena – tradizionalmente ritenute avere valenza meramente processuale -, abbia nondimeno inciso direttamente sul contenuto afflittivo della pena e quindi sulla stessa “natura della sanzione”, di fatto tramutata da “alternativa” in “detentiva”. Tenuta presente l’impostazione “sostanzialistica” ed “antiformalista” ormai affermatasi nella giurisprudenza della Corte EDU in relazione ad istituti che presentano marcati tratti di analogia con il peculiare regime esecutivo imposto per i reati di cui al citato art. 4-bis (richiamata nuovamente la decisione della Grande Camera del 21 dicembre 2013, Del Rio Prada c. Spagna), i mutamenti con effetti concretamente peggiorativi sul regime della sanzione inflitta, devono ritenersi avere natura, non processuale, ma sostanziale, con conseguente inapplicabilità retroattiva.
Infine, la difesa censura la costituzionalità dello stesso inserimento nel novero dei reati soggetti allo speciale regime di cui al citato art. 4-bis dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (in particolare, di quelli di cui agli art. 319, 319-ter e 321 cod. pen. che vengono in rilievo nella specie), in quanto in chiaro contrasto con la funzione rieducativa della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo dedotto con il ricorso principale è fondato per le ragioni di seguito esposte.
2. Giova premettere che l’art. 322-quater cod. pen., introdotto con la legge 27 maggio 2015, n. 69, prevede che “Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno”.
Occorre precisare come tale formulazione costituisca il frutto della modifica recentemente apportata con la legge 9 gennaio 2019, n. 3, là dove – ai fini della determinazione del quantum della riparazione pecuniaria – ha sostituito il riferimento a “quanto indebitamente ricevuto” dal funzionario pubblico con l’attuale riferimento alla”somma equivalente al prezzo o al profitto del reato”.
2.1. La riparazione pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen. ha natura esclusivamente economica e si parametra al vantaggio di natura patrimoniale derivato dalla condotta (profitto) ovvero al compenso dato o promesso per commettere il reato (prezzo) (Sez. U del 03/07/1996, n. 9149, Chabni Samir, Rv. 205707). La riparazione va corrisposta in favore dell’amministrazione cui appartiene il pubblico agente, a prescindere e, se del caso, in aggiunta rispetto al risarcimento” del danno cagionato al prestigio ed al buon funzionamento della pubblica amministrazione.
L’istituto presenta tratti di indubbio parallelismo con la “riparazione pecuniaria” prevista dall’art. 12 della legge 18 febbraio 1948, n. 47, applicabile in caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, là dove si applica “oltre al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 185 cod. pen.”.
Come si legge nei lavori preparatori della legge 27 maggio 2015, n. 69, il meccanismo della riparazione del danno, fissata in un’entità corrispondente a quanto indebitamente ricevuto, che deve essere versata a vantaggio dell’amministrazione di appartenenza, rappresenta una sanzione per l’infedeltà del pubblico ufficiale e per il danno cagionato all’amministrazione di appartenenza, con spiccata funzione dissuasiva.
In linea con l’intentio legisdel legislatore e con le indicazioni della migliore dottrina, nel lasciare del tutto impregiudicato il diritto della persona offesa al risarcimento del danno, a prescindere dalla denominazione, la riparazione muove dunque nella chiara prospettiva di realizzare un rafforzamento dell’armamentario sanzionatorio posto a tutela del buon andamento della pubblica amministrazione.
Deve, pertanto, ritenersi che la riparazione pecuniaria costituisca – come quella prevista dal citato art. 12 della legge sulla stampa – una “sanzione civile accessoria” alla condanna per i reati-presupposto di cui al catalogo dello stesso art. 322-quater cod. pen. L’istituto si presenta sotto forma di una “tipica” obbligazione civilistica – là dove ha un contenuto squisitamente economico ed è destinata alla persona offesa -, ma – giusta l’applicazione in termini di obbligatorietà, da parte del giudice penale, a prescindere dal danno civilisticamente inteso e dall’azione risarcitoria della parte civile, anche in aggiunta al risarcimento del danno – assume anche un’indubbia connotazione punitiva.
Stante la natura latu sensupunitiva della riparazione pecuniaria, la relativa applicazione – in assenza dei presupposti di legge – è certamente riportabile all’alveo della “pena illegale”, dando, dunque, luogo ad vizio coltivabile dinanzi a questa Corte ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
3. Tanto premesso quanto alla natura di “sanzione civile accessoria” della riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-quater cod. pen. ed alla sindacabilità nella sede di legittimità dell’applicazione di essa in violazione di legge, occorre rilevare, sotto diverso aspetto, come l’art. 322-quater cod. pen. preveda espressamente che la riparazione pecuniaria sia sempre ordinata con la “sentenza di condanna”.
Orbene, ritiene il Collegio – condividendo l’assunto difensivo – che detta espressione debba ritenersi riferita al provvedimento conclusivo del giudizio ordinario o abbreviato, ma non anche alla sentenza di applicazione della pena che, nel prescindere dall’accertamento positivo della penale responsabilità dell’imputato e giusta l’espressa previsione dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., è “solo” equiparata ad una pronuncia di condanna.
Conduce a tale conclusione anche il dato sistematico, là dove plurime disposizioni del codice penale – soprattutto quelle di recente introduzione anche nello specifico campo dei reati contro la pubblica amministrazione – confermano come il legislatore consideri eterogenea la “condanna” rispetto alla “applicazione della pena” ai fini delle ulteriori conseguenze penali derivanti dal reato.
Così, in particolare, le norme in tema di confisca obbligatoria di cui agli artt. 322-ter, 466-bis e 644, ultimo comma, cod. pen., le quali prevedono espressamente l’applicazione della misura di sicurezza patrimoniale anche in caso di sentenza di patteggiamento, in specifica deroga del disposto dell’art. 445, comma 1, cod. proc. pen.
Non può, inoltre, sfuggire come l’art. 322-quater cod. pen. sia stato inserito nel codice penale – nell’ambito del Titolo II, Capo I, dedicato alla disciplina dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. – immediatamente di seguito all’art. 322-ter che fa espresso riferimento, oltre alla “condanna” anche alla “sentenza di applicazione della pena”.
Si veda ancora il disposto dell’art. 609-nonies comma 1, cod. pen., nel quale il legislatore ha testualmente previsto l’applicazione delle pene accessorie e degli altri effetti penali in caso di “condanna” e di “applicazione della pena su richiesta delle parti”.
Tirando le fila delle considerazioni che precedono, non è revocabile in dubbio la netta distinzione, ai fini delle varie conseguenze sanzionatorie ed effetti penali, fra “condanna” propriamente detta e “sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti”.
Delineato il discrimenfra “condanna” e “sentenza di applicazione della pena”, ritiene allora il Collegio che la riparazione pecuniaria in oggetto – in quanto prevista soltanto per il caso di “condanna” – non possa trovare applicazione non solo nel caso di patteggiamento ordinario, ma anche in caso di patteggiamento c.d. allargato.
4. Né l’applicabilità della riparazione pecuniaria in caso di patteggiamento c.d. allargato può desumersi a contrariisdalla circostanza che, soltanto in caso di patteggiamento ordinario ex art. 445, comma 1, cod. proc. pen., l’imputato sia esente dall’applicazione delle “spese del procedimento”, “pene accessorie” e “misure di sicurezza” (salvo l’art. 240 cod. pen.).
Si è già posto in rilievo come la riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-quater presenti caratteristiche del tutto peculiari, che la pongono su di un piano di eterogeneità rispetto ai tradizionali istituti “penalistici” e che ne rendono problematico l’inquadramento nelle categorie delle “pene accessorie” o delle “misure di sicurezza”, costituendo essa piuttosto – come già rilevato – una sanzione di tipo civilistico, sui generisnel panorama del nostro codice penale. Detta connotazione ne impedisce allora l’applicazione al di fuori degli specifici casi nei quali essa sia espressamente prevista, in ossequio ai principi di legalità e di tassatività in materia penale.
Una conferma – sia pure indiretta – della inapplicabilità della riparazione pecuniaria in entrambe le ipotesi di patteggiamento si trae dall’art. 444, comma 1-ter, cod. proc. pen. – introdotto con la stessa legge n. 69 del 2015 che ha previsto l’art.322-quater -, là dove, nei procedimenti per i reati contro la pubblica amministrazione contemplati da tale disposizione, ha subordinato expressis verbisl’ammissibilità della richiesta di applicazione della pena”alla restituzione integrale de/prezzo o de/profitto de/reato”. Con ciò, senza fare alcuna menzione – né quale condizione, né quale effetto ulteriore – alla riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa dalla condotta del pubblico agente, fra l’altro, anch’essa commisurata “al prezzo o al profitto del reato” (in eventuale aggiunta al risarcimento del danno).
Non può allora sfuggire l’irragionevolezza di un’ermeneusi della norma che – nonostante l’assenza di una previsione espressa dell’applicabilità della riparazione pecuniaria anche in caso di sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. (nella forma ordinaria o c.d. allargata) – comportasse l’assoggettamento dell’imputato di taluno dei reati rientranti nel catalogo di cui all’art. 322-quater cod. pen., il quale intendesse appunto definire la propria posizione processuale con il patteggiamento, al doppio versamento di una somma eguale neltantundem(pari appunto al prezzo o al profitto del reato), sia pure a titolo diverso (restitutorio e riparatorio).
Ad ogni modo, stante la già rilevata non univocità della disposizione in oggetto quanto all’applicabilità della riparazione pecuniaria in caso di patteggiamento, non può non farsi ricorso al canone interpretativo generale in materia penale, alla stregua del quale non può che essere privilegiata, fra due possibili opzioni, l’interpretazione in favor rei.
Conclusivamente, deve essere affermato il principio di diritto secondo il quale, in tema di reati contro la pubblica amministrazione, il patteggiamento di una pena detentiva anche nella forma c.d. allargata preclude l’applicazione della riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-quater cod. pen., presupponendo essa la pronuncia di una sentenza di “condanna” propriamente detta, cioè resa a seguito di rito ordinario o abbreviato.
5. Passando alla disamina della questione di incostituzionalità dell’art. 6, comma 1, lett. b), legge 9 gennaio 2019, n. 3, là dove ha inserito i reati contro la pubblica amministrazione tra quelli “ostativi” ai sensi dell’art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, senza prevedere un regime intertemporale, giova preliminarmente evidenziare – sul piano dell’ammissibilità del motivo – che, la questione attiene ad una disposizione entrata in vigore in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata ed al deposito del ricorso originario, di tal che non avrebbe potuto essere prospettata dal F. all’atto della presentazione dell’impugnazione. Ad ogni modo, si tratta di una sollecitazione rivolta a questa stessa Corte a sollevare la questione.
Come si è già anticipato, il ricorrente sollecita l’incidente di costituzionalità sotto un duplice profilo: in relazione, da un lato, all’omessa previsione di un regime di diritto intertemporale; dall’altro lato, all’inserimento dei reati contro la pubblica amministrazione (in particolare quelli che vengono in rilievo con riferimento alla posizione del F.) fra i “reati ostativi” contemplati dall’art. 4-bis ord. penit.
6. La questione di incostituzionalità concernente l’assenza di un regime di diritto intertemporale, per quanto non manifestamente infondata, risulta nondimeno non rilevante nella specie, per le ragioni esposte nel prosieguo.
6.1. Può convenirsi con il ricorrente che l’omessa previsione di una disciplina transitoria circa l’applicabilità della disposizione (come novellata) possa suscitare fondati dubbi di incostituzionalità in relazione ai riverberi processuali sull’ordine di esecuzione, in quanto non più suscettibile di sospensione in forza della previsione dell’art. 656, comma 9, cod. proc. pen.
Va difatti considerato come, secondo il disposto della lettera a) del comma 9 dell’art. 656, la sospensione dell’ordine di esecuzione della sentenza di condanna ad una pena detentiva non superiore a quattro anni (giusta anche la declaratoria d’incostituzionalità con sentenza della C. Cost. 2 marzo 2018, n. 41) per il termine di trenta giorni al fine di consentire al condannato in stato di libertà di avanzare istanza di concessione di una delle misure alternative previste dalla legge n. 354 del 1975 – sospensione prevista dal comma 5 dello stesso articolo – non possa essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti di cui al citato art. 4-bis.
Orbene, avuto riguardo al “diritto vivente”, quale si connota alla luce del diritto positivo e della lettura giurisprudenziale fino ad ora consolidata a seguito della decisione delle Sezioni Unite del 2006, le disposizioni concernenti l’esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione, non riguardando l’accertamento del reato e l’irrogazione della pena, ma soltanto le modalità esecutive della stessa, sono considerate norme penali processuali e non sostanziali e, pertanto, ritenute soggette – in assenza di una specifica disciplina transitoria – al principio tempus regit actume non alle regole dettate in materia di successione di norme penali nel tempo dall’art. 2 cod. pen. e dall’art. 25 Cost. (Sez. U, n. 24561 del 30/05/2006, P.M. in proc. A., Rv. 233976; Sez. 1, n. 46649 del 11/11/2009, Nazar, Rv. 245511; Sez. 1, n. 11580 del 05/02/2013, Schirato, Rv. 255310). In applicazione di tale interpretazione, con riferimento ai reati ascritti al ricorrente, non sarebbe più possibile disporre la sospensione dell’esecuzione ai sensi del combinato disposto dell’art. 656, comma 9, cod. proc. pen. in base all’art. 4-bis ord. penit. (come novellato nel gennaio 2019).
6.2. D’altra parte, non è revocabile in dubbio che, nella più recente giurisprudenza della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, ai fini del riconoscimento delle garanzie convenzionali, i concetti di illecito penale e di pena abbiano assunto una connotazione “antiformalista” e “sostanzialista”, privilegiandosi alla qualificazione formale data dall’ordinamento (all'”etichetta” assegnata), la valutazione in ordine al tipo, alla durata, agli effetti nonché alle modalità di esecuzione della sanzione o della misura imposta.
Significativa in tale senso è la pronuncia resa nel caso Del Rio Prada contro Spagna (del 21 ottobre 2013), là dove la Grande Camera della Corte EDU, nel ravvisare una violazione dell’art. 7 della Convenzione, ha riconosciuto rilevanza anche al mutamento giurisprudenziale in tema di un istituto riportabile alla liberazione anticipata prevista dal nostro ordinamento in quanto suscettibile di comportare effetti peggiorativi, giungendo dunque ad affermare che, ai fini del rispetto del “principio dell’affidamento” del consociato circa la “prevedibilità della sanzione penale”, occorre avere riguardo non solo alla pena irrogata, ma anche alla sua esecuzione (sebbene – in quel caso – l’istituto avesse diretto riverbero sulla durata della pena da scontare).
6.3. Alla luce di tale approdo della giurisprudenza di Strasburgo, non parrebbe manifestamente infondata la prospettazione difensiva secondo la quale l’avere il legislatore cambiato in itinere le “carte in tavola” senza prevedere alcuna norma transitoria presenti tratti di dubbia conformità con l’art. 7 CEDU e, quindi, con l’art. 117 Cost., là dove si traduce, per il F., nel passaggio – “a sorpresa” e dunque non prevedibile – da una sanzione patteggiata “senza assaggio di pena” ad una sanzione con necessaria incarcerazione, giusta il già rilevato operare del combinato disposto degli artt. 656, comma 9 lett. a), cod. proc. pen. e 4-bis ord. penit.
D’altronde, in precedenza, il legislatore aveva adottato disposizioni transitorie finalizzate a temperare il principio di immediata applicazione delle modifiche all’art.4-bis ord. penit., quali quelle contenute nell’art. 4 d.l. n. 13 maggio 1991, n. 152, e nell’art. 4, comma 1, I. 23 dicembre 2002, n. 279 (che inseriva i reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 cod. pen. nell’art. 4-bis cit.), limitandone l’applicabilità ai soli reati commessi successivamente all’entrata in vigore della legge.
7. Se non che, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, i delineati profili di incostituzionalità pertengono, a ben vedere, non al patto stipulato fra le parti e ratificato dal giudice, né alla pena applicata su richiesta – di per sé validi e “indifferenti” alla novella normativa del 2019 -, bensì alla mera esecuzione della sanzione, incidendo, come si è già detto, sulla sospendibilità, rectiusnon sospendibilità, dell’ordine di esecuzione.
Conferma evidente di tale assunto si trae dalla stessa premessa del ricorrente, là dove sollecita questa Corte a promuovere l’incidente di costituzionalità “riconosciuta la propria competenza a conoscere della fase esecutiva del presente procedimento”. Con ciò, trascurando di considerare come, a norma 665 cod. proc. pen., la Corte di cassazione non sia mai giudice dell’esecuzione del provvedimento oggetto di impugnazione.
In altri termini, la questione di incostituzionalità prospettata afferisce non alla sentenza di patteggiamento oggetto del presente ricorso, ma all’esecuzione della pena applicata con la stessa sentenza, dunque ad uno snodo processuale diverso nonché logicamente e temporalmente successivo, di talché ai fini della decisione di questa Corte non rileva, potendo se del caso essere riproposta in sede di incidente di esecuzione.
8. In conclusione, in accoglimento del motivo dedotto con il ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, nella parte in cui ha ordinato all’imputato, ai sensi dell’art. 322-quater cod. pen., di pagare alla ASL Roma 1 la somma di euro 330.00 a titolo di riparazione pecuniaria.
Vanno invece rigettate le questioni di costituzionalità, fatte valere con i motivi nuovi, perché non rilevanti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta riparazione pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen., che elimina.
Così deciso il 14 marzo 2019
Il consigliere estensore Il Presidente
Alessandra Bassi Giorgio Fidelbo